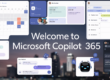Nelle aziende si parla molto di intelligenza artificiale, ma troppo spesso la conversazione resta sospesa tra demo spettacolari e timori dirompenti. Un AI Strategist esiste per riportare tutto a terra: traduce la tecnologia in risultati economici misurabili, ridisegna i processi perché quei risultati accadano davvero e guida l’organizzazione mentre cambia pelle. È una figura ibrida, a metà tra consulente di direzione e architetto del digitale, con una missione chiara: fare in modo che l’AI sposti i numeri del conto economico, non solo le slide.
Il suo lavoro comincia sempre dal business, non dall’algoritmo. Incontra i responsabili di funzione e pone domande semplici: dove perdiamo tempo? dove si genera scarto? quali decisioni arrivano tardi? La mappa dei colli di bottiglia che ne deriva diventa il punto di partenza per costruire una tesi di valore: non una lista di tool, ma pochi casi d’uso con obiettivo, baseline e impatto atteso. Se un’azienda soffre di tempi lunghi nella riconciliazione contabile, la proposta non sarà “mettiamo un modello generativo”: sarà “ridisegniamo il ciclo AP/AR, automatizziamo l’estrazione dei dati dai documenti, introduciamo controlli automatici e liberiamo il 40% del tempo del team finance entro il trimestre”. Parlare così significa assumersi la responsabilità del risultato.
Definita la tesi, l’AI Strategist lavora sulle fondamenta. Senza dati accessibili, puliti e governati, l’AI è un castello di sabbia. Qui entrano in gioco l’architettura informativa e l’integrazione con i sistemi esistenti: ERP, CRM, piattaforme di produzione, repository documentali. L’obiettivo non è costruire la “cattedrale” tecnologica perfetta, ma una base sufficiente a scalare in sicurezza: pipeline dati tracciabili, controlli di qualità, ruoli chiari su chi pubblica, chi consuma, chi monitora. È un passo spesso invisibile, ma è quello che distingue un pilot che funziona in laboratorio da una trasformazione che regge al contatto con l’operatività quotidiana.
Il momento decisivo arriva quando il caso d’uso entra nel processo. L’AI Strategist sa che i modelli non vivono da soli: devono essere incastonati nel flusso di lavoro reale, dentro gli strumenti che le persone già usano. Un copilota per il customer service non è una chat separata, ma un’estensione del sistema di ticketing che legge la cronologia, propone una risposta, cita le fonti e rispetta le policy. Un algoritmo di manutenzione predittiva non è un grafico in più, ma un modo diverso di pianificare turni, ricambi e fermate. È in questo “ultimo miglio” che l’AI smette di essere un progetto IT e diventa performance operativa.
La tecnologia, da sola, non basta. L’AI Strategist dedica tempo alla gestione del cambiamento. Le persone devono capire perché si cambia, cosa cambia e come sarà misurato. Servono formazione, playbook, criteri di qualità. Serve soprattutto definire il ruolo dell’umano nel ciclo di decisione: quando l’AI propone, chi approva? con quali soglie? con quali responsabilità? Un impianto “human-in-the-loop” ben progettato riduce i rischi e aumenta la fiducia: è il vaccino contro l’adozione fittizia, quella in cui lo strumento c’è ma nessuno lo usa davvero.
Accanto all’adozione c’è la governance. Un CEO non può tollerare una scatola nera. L’AI Strategist imposta regole chiare su dati sensibili, proprietà intellettuale, sicurezza, audit e conformità normativa. Introduce metriche di qualità degli output, controlli sui bias, procedure di escalation se qualcosa va storto. E soprattutto misura il valore con la stessa disciplina con cui si misurano vendite e costi: tempi ciclo, first-pass yield, cost-to-serve, margine incrementale. Senza numeri, l’AI resta narrativa; con i numeri, diventa gestione.
C’è poi il tema del mercato dei fornitori, affollato e rumoroso. L’AI Strategist agisce da selezionatore indipendente. Conosce i limiti delle piattaforme, i costi reali di esercizio, i rischi di lock-in. Sceglie ciò che serve davvero, combinando soluzioni pronte, sviluppo su misura e automazioni low-code. L’obiettivo non è collezionare strumenti, ma mantenere il controllo architetturale e la flessibilità economica: spendere dove l’impatto è alto, standardizzare dove non crea vantaggio.
Il lavoro non finisce con il primo successo. Un buon AI Strategist costruisce un portafoglio di iniziative che si alimentano a vicenda: ciò che si impara in finance accelera l’automazione nel customer service; ciò che si normalizza nei dati di produzione migliora il forecasting della supply chain. Nel tempo, questo portafoglio diventa un vero e proprio sistema di performance: una piattaforma di casi d’uso, dati, modelli e competenze interne che rende l’azienda più veloce, più precisa e più resiliente. È la differenza tra “avere qualche progetto AI” e “operare come un’impresa aumentata”.
Infine, c’è la dimensione culturale. L’AI porta con sé un modo nuovo di lavorare: più sperimentazione, più misura, più collaborazione tra funzioni. L’AI Strategist coltiva questa cultura con piccoli gesti quotidiani—retrospettive brevi, benchmark interni, condivisione delle lezioni apprese—e con scelte strutturali—obiettivi legati all’adozione, responsabilità esplicite, incentivi all’uso. La tecnologia passa, la cultura resta: è ciò che consente di continuare a estrarre valore quando i modelli cambiano e i mercati accelerano.